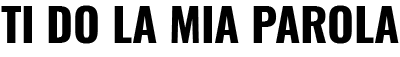Curating curatorial hostipitality. Appunti su ospitalità e curatela.
La scorsa primavera, durante un evento intitolato Potential Wor(l)ds – Making Spaces On Our Own Terms presso la Fondazione Lighthouse a Brighton, sono stata testimone delle molteplici implicazioni di affrontare il tema dell’ospitalità come oggetto curatoriale.
Eva Rowson, curatrice in residenza, aveva organizzato l’evento invitando alcuni membri della scena artistica locale per condividere le loro strategie sullo sviluppo di modelli e politiche di ospitalità alternativi a quelli proposti dalle tradizionali istituzioni culturali. (1) Nella stanza sedie impilate, sgabelli, cuscini e coperte erano a disposizione del pubblico da disporre secondo il proprio piacimento. Sui piccoli tavolini sparsi per la sala abbondava cibo vegano, insieme a del pane prodotto da una piccola azienda locale. L’ospitalità era messa in scena sia fisicamente che a livello discorsivo come un incontro intimo e amichevole.
Ciononostante, nel momento di domande e risposte, un membro del pubblico ha iniziato ad avanzare con risolutezza una serie di critiche riguardo al cibo – vegano si, ma non adatto a persone celiache – e a palesare un certo fastidio dovuto alla scelta di creare per quella sera dei bagni senza distinzione di genere. La reazione degli oratori, presi alla sprovvista dall’intervento come il resto dei partecipanti, è stata varia: alcuni hanno invitato l’ospite ad una conversazione privata, cercando di mettere da parte la questione con visibile imbarazzo; altri si sono scusati, ed altri ancora hanno espresso apprezzamento per il coraggio e l’onestà dimostrati. In ogni caso, l’atmosfera si era lentamente guastata, ed un velo di imbarazzo era andato sostituendosi all’iniziale intimità.
Mi sembrò subito interessante come l’evento, che nasceva dall’esigenza di evidenziare l’inadeguatezza delle istituzioni culturali tradizionali ad essere effettivamente aperte ed inclusive, era riuscito al contempo a manifestare una serie di difficoltà insite nell’idea stessa di inclusione e accoglienza. Infatti il membro dell’audience, mettendo in discussione le scelte del curatore, rende manifesta la minaccia inerente all’ospitalità; cioè ricorda improvvisamente ai presenti che l’atto di accoglienza implica necessariamente un certo livello di imprevedibilità e instabilità, all’interno del quale si crea uno spazio di vulnerabilità in cui coabitano sia la generosità che l’ostilità, l’ospitalità e l’inospitalità.
Che cosa intendiamo dunque quando ci riferiamo al concetto di ospitalità? Quali sono le dinamiche che vengono messe in atto, in che modo e fino a che punto essa è influenzata da un sentimento di ostilità? E ancora, come definiamo le figure di ospite e padrone, la loro relazione, e come esse si manifestano nell’ambito curatoriale?
Considerando la curatela come un atto di ospitalità all’interno del sistema artistico, farò riferimento alla distinzione proposta del filosofo Jacques Derrida tra ospitalità assoluta e condizionata, e a quella della curatrice Maria Lind tra curatoriale e curatela come i miei riferimenti teorici principali. Lungo queste traiettorie cercherò di analizzare che cosa significa parlare di ospitalità curatoriale, quali sono gli attori coinvolti e che tipo di relazione si instaura tra di loro. Infine cercherò di tratteggiare i contorni di quello che definirò curating curatorial hostipitality, una possibile modalità attraverso cui riflettere sulle molteplici implicazioni delle pratiche di ospitalità, e che tenga conto del ruolo svolto dall’ostilità in tale contesto.
. . . .
Sul tema dell’ospitalità, il contributo offerto da Jacques Derrida è stato largamente dibattuto in ambiti diversi. Durante gli anni novanta, il filosofo algerino-francese ha scritto in modo esaustivo ed ha tenuto conferenze sulla materia, come dimostra il libro Sull’Ospitalità (2000) che include la trascrizione di due lezioni del 1996 – Questione dello straniero venuto da fuori e Passo d’ospitalità – insieme al commento di Anne Dufourmantelle. Nel lavoro di Derrida, il termine ospitalità rappresenta un mezzo attraverso cui ripensare questioni politiche ed etiche, sia a livello sociale che del singolo individuo, e permette la decostruzione delle figure di ospite (guest) e del proprietario di casa (host).
Nei sui scritti, Derrida distingue tra ospitalità incondizionata e condizionata: la prima rappresenta un’apertura radicale verso un assoluto e indistinguibile altro, un’accoglienza priva di restrizioni o inviti. Al contrario, la nozione di ospitalità condizionata si fonda sulla legge del diritto, perciò riguarda principalmente aspetti pragmatici che definiscono la relazione tra ospite e padrone. Nonostante la nozione di ospitalità incondizionata abbia ottenuto particolare attenzione nel contesto artistico, il mio interesse si rivolge soprattutto al modo in cui Darrida ha definito la relazione di questi due concetti in termini di aporia. Se da un lato risulta impossibile risolvere il conflitto tra ospitalità incondizionata e condizionata, il filosofo ci mette di fronte al fatto che tale conflittualità rappresenta un elemento inscindibile dall’essenza stessa dell’ospitalità. “L’ospitalità assoluta rompe con l’ospitalità di diritto; non che la condanni o vi si opponga, e lei può metterla al contrario e tenerla in un movimento incessante di progresso; ma gli è tanto eterogeneo, che la giustizia è eterogena al diritto di cui è tuttavia così vicina e in verità indissociabile” (Derrida, J. & Dufourmantelle, A., 2000, p. 27). Perciò, riflettere sull’idea di ospitalità implica confrontarsi con i suoi aspetti pratici, le sue limitazioni; significa riflettere in termini di contraddizioni interne.
Nel definire le figure di ospite e padrone, Jacques Derrida fa riferimento alla definizione etimologica proposta da Emelie Benveniste, la quale distingue i due soggetti in base alla capacità di esercitare un controllo sopra una proprietà. Infatti la parola Latina hospes è l’unione di hostis, lo straniero – nell’ accezione sia di ‘forestiero’ che di ‘nemico’ – e potes, il padrone, colui che esercita una sovranità. Tale disparità di potere e ciò che favorisce l’emergere di una certa ostilità tra di loro. Infatti, sebbene il padrone abbia il potere di accogliere o meno lo straniero dentro la sua casa, l’ospite, una volta accettato, può potenzialmente minacciare la posizione di potere del padrone sovvertendo le regole che gli sono imposte, e divenendo un avversario che mettere in pericolo l’esistenza stessa della sua figura (Derrida, 2000). Per definire questa minaccia insita nel rapporto di ospitalità, Derrida nel 2000 ricorre al neologismo inglese hostipitality che unisce il termine inglese di ospitalità – hospitality – e di ostilità – hostility (Derrida, 2000). Secondo questa visione, è dunque possibile analizzare la questione dell’ostilità non come opposta all’idea di ospitalità, ma come sua controparte inscindibile.
In questa mutualità, anche le figure di padrone e ospite non sono staticamente definite, ma al contrario si manifestano in una struttura dinamica, come entità che simultaneamente giustificano, garantisco e minacciano l’uno l’esistenza dell’altro. Mirielle Rosello nel suo libro Postcolonial Hospitality. The immigrant as a guest (2001) ha rimarcato questo aspetto affermando che l’ospitalità è “interpretata e reinterpretata su molti livelli, su una moltitudine di attori la cui posizione di potere e impotenza è non solo relativa ma anche disconnessa dalle loro identità” (in Bismark, von, 2016, p 13). In quanto soggetti che assumo ruoli temporanei in relazione al variare delle circostanze, sia l’host che il guest non trovano mai una collocazione univoca, ma si manifestano e si sovvertono ridefinendosi costantemente.
L’importanza della conflittualità nei rapporti sociali, è un punto cruciale all’interno dell’opera della politologa belga Chantal Mouffe, che promuove una visione della democrazia basata sull’antagonismo in cui predominano pratiche di dissenso anziché di consenso. In questo contesto, Mouffe delinea la figura dell’avversario come colui che mette in discussione il potere egemonico al fine di stabilire una contro egemonia, ed è l’elemento centrale che sostiene l’atto democratico stesso. Nel libro Il conflitto democratico (2016) Mouffe articola il formarsi della figura dell’avversario basandosi sul concetto di ‘esterno costitutivo’ formulata da Henry Staten (1985), e sottolinea come ciò conduca all’emergere di un sentimento di antagonismo. “Esso [l’esterno costitutivo] mira a mettere in evidenza il fatto che la creazione dell’identità implica la definizione di una differenza, una differenza che è spesso costruita sulla base di una gerarchia. Una volta che abbiamo compreso che ogni identità è relazionale e che l’affermazione di una differenza – per esempio la percezione di qualcosa di ‘altro’, di ‘esterno’ – è precondizione per l’esistenza stessa di una identità, allora possiamo iniziare a immaginare come una relazione sociale possa divenire un terreno fertile per l’antagonismo.”< (Mouffe, 2016). (2) Seguendo l’ipotesi proposta da Mouffe, se consideriamo le figure di padrone e ospite come identità relazionali allora dovremmo prendere in considerazione che la loro coesistenza contempli l’antagonismo come elemento strutturale. L’ospite è l’avversario che, con la sua stessa presenza, impone al padrone di casa di riconoscere se stesso come identità altra. Al contempo, la minaccia che l’ospite possa sovvertire l’ordine gerarchico e di potere stabilito – che possa cioè prendere possesso della proprietà che appartiene al padrone – favorisce il concretizzarsi della loro differenza di potere, e apre la strada alla possibilità di antagonismo. Considerando l’ostilità come elemento costitutivo della relazione tra padrone e ospite, diventa urgente pensare ad approcci in grado di mettere in scena l’antagonismo come forma appunto di hostipitality.
. . . .
La questione dell’ospitalità è da molto tempo un elemento centrale del discorso curatoriale, in particolare a causa delle similitudini tra questi due ambiti sia a livello discorsivo che rappresentativo. In particolare, molti nel settore hanno discusso riguardo alla possibilità di applicare il concetto di Jacques Derrida di ospitalità incondizionata alle pratiche curatoriali (Esche, 2005; Fusi, 2012,2016; Schafaff, 2016). Nonostante questo dibattito assai vivace, credo che ben poca attenzione sia stata data alle potenzialità di applicare il concetto di hostipitality, cioè di confrontarsi con il ruolo giocato dall’ostilità e dall’antagonismo nell’ambito curatoriale.
A livello teorico, un tassello importante è rappresentato dal contributo della curatrice e critica Maria Lind, che nel 2009 sistematizza, in un articolo pubblicato su Artforum, la distinzione e la relazione tra ‘curatoriale’ – ‘the curatorial’ – e curatela – ‘the curating’. Con curatoriale intende “il modo di pensare per interconnessioni: collegare oggetti, immagini, processi, persone, luoghi, storie e discorsi all’interno di uno spazio fisico”. Al contempo, le “modalità tecniche di rendere l’arte pubblica”, cioè il format della mostra, quello dei simposi, degli screening e tutte quelle attività relative alle pratiche espositive, sono ciò che costituiscono la curatela (Lind, 2009, 2012). Più avanti, Lind chiarisce che queste due sfere interagiscono tra loro al fine di creare pratiche relative a specifici contesti che, a partire dall’arte e dalle sue necessità, sviluppino un discorso in grado di espandere e sfidare le modalità tradizionali di presentazione dell’arte prendendo in considerazione le complessità che i singoli lavori veicolano (Hoffmann and Lind, 2011). Nella sua stesse definizione inoltre, Lind ricorre indirettamente al concetto di antagonismo di Chantal Mouffe mettendo in parallelo il concetto di ‘curatorial’ con quello di ‘political’ – e quindi quello di ‘curating’ con la definizione di ‘politics’. (3) Il curatoriale rappresenta dunque tutto ciò che non riguarda più soltanto l’esposizione di opere, ma diviene una disciplina in grado di generare, contestualizzare e rendere pubbliche idee legate alle opere. In questa sua dimensione, il curatoriale diviene un elemento in grado di generare una frizione, una discontinuità che, mettendo in discussione lo status quo delle pratiche espositive, favorisce l’emergere dei limiti interni alle sue stesse dinamiche, e rende possibile l’attuazione di nuove strategie. Accostando l’antagonismo politico all’ambito curatoriale, Maria Lind apre alla formulazione dell’idea di curating curatorial hostipitality, cioè la possibilità di ripensare le pratiche di ospitalità curatoriale attraverso la teorizzazione delle conflittualità in esse contenute.
Beatrice von Bismarck’s e Benjamin Meyer-Krahmer hanno affermato che “una situazione curatoriale è sempre di ospitalità” (2016, p. 8). Essa include l’atto di invitare persone (artisti, scrittori, visitatori etc.), offrire loro un supporto concreto (in termini di tempo, spazio, risorse economiche o materiali) e risorse affettive (cura, rispetto, riconoscimento e prestigio). In questo contesto le figure di ospite e padrone vengono spesso associate ad artisti e visitatori da un lato, ed a curatori e istituzioni dall’altro, ma tale distinzione è soggetta a costante cambiamento.
Tradizionalmente la figura del curatore si associa a quella di colui che si prende cura di, in relazione all’origine dalla parola latina curare, un’attitudine che si manifesta attraverso il rispetto e l’apprezzamento del lavoro dell’artista e la messa a disposizione di una serie di risorse. A dispetto di un apparente carattere puramente positivo, l’attuale direttrice del MoMA PS1 Kate Fowle ha notato come il termine curatore possa anche riferirsi a “qualcuno che presidia su qualcosa” (Fowle, 2010, p.26). Questa caratteristica è di fatto riscontrabile nelle pratiche di selezione, organizzazione e presentazione degli artisti e dei loro lavori, che manifestano una certa “ambivalenza tra il prendersi cura e il custodire […], esemplificando forme di assoggettamento a standard e criteri preesistenti, e questo costituisce la base sia per la gerarchizzazione che l’esclusione” (Bismarck, von. 2016, p.10). L’atto della curatela dunque si trova sempre impigliato tra le pratiche di inclusione e di esclusione, decontestualizzazione, appropriazione e ricollocazione.
Per questa ragione, anche il tentativo di Anthony Huberman di identificare il curatore come ‘ospite dell’artista, sembra obliterare la duplice natura presente nel suo ruolo, promuovendone al contrario una visione statica. “Come curatori, siamo sempre gli ospiti degli artisti con cui decidiamo di lavorare. Bussiamo alle loro porte e chiediamo loro se vogliono che trascorriamo del tempo nel loro studio […]. Questo non significa che non ci sia spazio affinché la mia voce venga ascoltata. […] Non me ne starò seduto al tavolo in silenzio senza dire niente. Sarebbe scortese” (Huberman, 2012, p. 60). Tale immagine appare fuorviante se consideriamo le dinamiche relazionali tra ospite e padrone di cui abbiamo discusso finora. Nonostante il tentativo di denunciare la spesso ingombrante presenza del curatore nel lavoro dell’artista, la posizione di Huberman offre una scappatoia di fronte alle complessità che il suo ruolo di fatto comporta.
Promuovendo un’immagine predominantemente positiva, il potere del curatore è sottorappresentato e compromesso. Come Roelstraete ha sottolineato, l’importanza del legame che si crea tra curatore e artista non dovrebbe offuscare la natura dialettica di questa relazione, ma al contrario rinforzare la creazione di uno spazio dove codici impliciti e taciuti sono messi in discussione e dove “c’è spazio sia per cattivi ospiti che per i cattivi padroni di casa” (2016, p. 30). A tale riguardo, Jörn Schafaff parla del progetto dell’artista Rirkit Tiravanija untitled 1994 (meet tim & burkhard) (2016) sottolineando come esso sia stato in grado di evidenziare l’instabilità della relazione di ospitalità, in cui “la posizione dell’ospite non è in alcun modo priva di potere, così come il potere del proprietario della galleria non è in alcun modo incondizionato o illimitato” (2016, p.154). Infatti in questo suo lavoro seminale Tiravanija, considerato l’artista dell’ospitalità per eccellenza, trasforma la galleria in un salotto in cui mettere in scena l’incontro con i due direttori della gallerie berlinese neurgerriemschneider, Tim Neuger e Burkhard Riemschneider. Non ci sono opere all’interno, solo una serie di mobili – alcuni dei quali provenienti direttamente dall’appartamento dei galleristi – e una video intervista dei direttori: il vero oggetto estetico è l’incontro stesso. L’artista, divenuto curatore dell’evento, stravolge la gerarchia degli attori coinvolti trasformando i proprietari della galleria in ospiti, e sostituendosi ad essi insieme agli spettatori, ed effettuando quindi quella inversione di ruoli tra ospite e padrone di cui abbiamo parlato fino a qui (Schafaff, 2016, 154-155).
Anche l’atto stesso di mettere a disposizione risorse materiali – del ‘dare spazio ’, cioè l’elemento che distingue in primo luogo il padrone dall’ospite secondo Derrida – manifesta una sua duplice natura, in cui coesistono sia generosità che desiderio di prestigio e visibilità, secondo quella che von Bismarck definisce come “logica paradossale del dare” (2016, p.11). Infatti, ‘prendersi cura di’ può facilmente diventare una pratica di ‘parlare per’, il cui risultato finale consiste nel rafforzamento delle disparità di potere. Helena Reckitt ha chiarito come questa struttura lavori nell’attuale economia dell’arte, dove l’identificazione della curatela con l’atto del prendersi cura ha nel tempo incrementato il prestigio pubblico della figura del curatore e la vulnerabilità diventa una qualità da preservare in quanto garante di una certa autorità (2016 pp. 10-11). Andrea Fraser addirittura ha descritto la relazione di ospitalità in ambito curatoriale in termini psicoanalitici come “assunti di base” dove “l’empatia del prendersi cura” coesiste con “l’ansia di nuocere a” producendo una relazione di dipendenza (Fraser, 2016,p.42-43).
La questione dell’ospitalità in ambito curatoriale interessa anche i modi in cui le istituzioni si rendono disponibili al pubblico. Da un punto di vista pratico, ciò riguarda l’accessibilità del pubblico ai luoghi dell’arte, e spesso fa uso di una serie di pratiche di marketing strategico che implementano il raggiungimento di un più ampio raggio di visitatori attraverso la distribuzione di intrattenimento in forma di partecipazione ed esperienza personalizzata (Baker, 2002; Black, 2012; Fraser, 2006). Per questo, il concetto di ospitalità ha influenzato il lavoro di molti curatori richiamando l’attenzione su le logiche che regolano le strategie di accoglienza delle istituzioni. Ad esempio, il curatore Charles Esche ha parlato di ‘ospitalità radicale’ come la spinta principale nello sviluppo del programma del The Van Abbenmuseum che permettesse un’apertura più critica e al tempo stesso approcciabile della programmazione (Steihaug, Ekeberg, 2011). Radicale si riferisce a un deciso impegno nel promuovere progetti che privilegiano una “ricerca dialogica” e metodi “di insegnamento collettivi sperimentali”; qui l’ospitalità è intesa in senso incondizionato, come la capacità cioè di dire si a chiunque si presenti (Farquharson, 2012 p.55). (5) La pratica curatoriale di Esche incoraggia la creazione di spazi di sperimentazione, capaci sia di rispondere ai trend dell’arte che a creare spazi dove “le persone si sentono benvenute e in grado, se lo desiderano, di affermare il loro senso di alienazione da qual tipo di sperimentazione che portiamo avanti” (Steihaug, Ekeberg, 2011). Successivamente si è riflettuto come, nonostante l’insistenza sull’importanza di “riconsiderare le funzioni socio politiche del museo” (Farquharson, 2012 p. 56) il risultato talvolta non si sia rivelato all’altezza delle aspettative. Lo stesso programma promosso da Charles Esce, si è rivelato con il tempo talmente intimo da compromettere la sua stessa risonanza: “ In pratica, le nuove istituzioni spesso coinvolgono solo gruppi relativamente ridotti, le cui politiche e soggettività rimangono più o meno allineate a quelle degli attori istituzionali” ( Farquharson, 2012, p.56). Alla fine, questo sforzo ha prodotto una spazio in cui l’unanimità delle voci presenti diminuiva le proposizioni su cui si fondava l’argomento proposto.
La costruzione di “comunità microtopiche” dove l’empatia umana e l’atmosfera auto-congratulatoria prevale sulle frizione e il senso di disconforto, è ciò che Claire Bishop ha criticato nell’esperienza di Nicolas Bourriaud e dell’ Estetica Relazionale (2004, p.79). Partendo dalla definizione di antagonismo proposta da Chantal Mouffe (2001), Bishop afferma che per creare un contesto democratico non è abbastanza produrre lavori che richiedono la partecipazioni degli spettatori per essere attivati, ma c’è bisogno di valutare la qualità delle relazioni stabilite. Intendendo ridefinire la relazione tra gli aspetti sociali ed estetici dell’arte, Bishop afferma che se un’opera ignora ogni possibilità di esclusione, o fallisce di riconoscere privilegi ed elitismo, allora non è possibile che tale opera venga considerata né sociale né politica.
Sebbene Claire Bishop si focalizzi principalmente sulla critica delle pratiche artistiche di Rirkrit Tiravanija e Liam Gillick, contrapponendole alle esperienze di Thomas Hirschhorn e Santiago Serra, richiama anche l’attenzione sull’importanza di considerare l’antagonismo come una forza costitutiva all’interno del contesto curatoriale e in grado di promuovere istanze politiche e democratiche.
Quando analizziamo le dinamiche dell’ospitalità curatoriale e il ruolo ambivalente degli attori coinvolti, ci troviamo ad affrontare necessariamente i loro aspetti inospitali, i paradossi interni.
Il ragionamento qui proposto, vuole mostrare la difficoltà e insieme la necessità di decostruire l’ospitalità in ambito curatoriale innanzitutto da un punto di vista teorico. Ho cercato di delineare come il lavoro di Jacques Derrida abbia favorito una distinzione sistematica del concetto di ospitalità, distinguendola tra assoluta e condizionata. La loro relazione si manifesta attraverso una conflittualità irriducibile tra questi due termini che si oppongono e completano allo stesso tempo, divenendo hostipitality. Al contempo, le figure di ospite e padrone di casa continuano a manifestare tale conflittualità in quanto entità relazionali, dove ciascuna esistenza è giustificata attraverso la manifestazione del suo opposto complementare.
Abbiamo poi visto che è possibile rintracciare le stesse dinamiche all’interno della sfera curatoriale, grazie al contributo offerto da Maria Lind che distingue tra il curatoriale e la curatela ponendo la stessa attenzione sull’antagonismo che ne deriva. In tale contesto, curatori, artisti, istituzioni e pubblico assumo di volta in volta il ruolo di ospiti o di padroni.
Curating curatorial hostipitaly è un invito dunque a ripensare le teorie e le pratiche relative all’ospitalità curatoriale tenendo conto dell’influenza esercitata dalle dinamiche oppositive che esse contengono per esporle, e attraverso di loro, spingersi verso un rinnovamento dei suoi stessi principi. Significa pensare a come includere la tensione nelle pratiche di accoglienza riconoscendole non come eccezionalità da limitare, ma come elemento insito nell’idea stessa di ospitalità.
L’altro passo sarà quello di pensare a come sia possibile decostruire il concetto stesso di territorialità, di confine, di casa e ,di conseguenza, l’idea stessa di ospite e padrone. Ma questa forse, è una possibilità di cui parlare in futuro.
(1) Potential Wor(l)ds - Making Spaces On Our Own Terms era il primo di quattro eventi parte del programma Who’s doing the washing up — where’s the sink? (Gennaio -Luglio 2019). Gli artisti partecipanti includevano Aliyah Hussain e Anna Bunting Branch, il co-direttore artistico del Marlborough Theatre Tarik Elmoutawakil e le organizzatrici del Devils’ Dyke Network, Claudia Treacher e Violeta Marchenkova. Gli eventi successivi: Send and Receive: Maia Urstad and Anton Kats (MAKU), Cuñas, topes y sujetapuertas / doorstops, wedges and holding space: Jordi Ferreiro and Andrea Francke and There ought to be a word: Aliyah Hussain and Anna Bunting Branch in conversation with Devils’ Dyke Network. Per maggiori informazioni: www.lighthouse.org.uk/programme/light-season-3-who-s-doing-the-washing-up (2) Chantal Mouffe spiega in modo comprensivo il suo ‘modello agonistico’ in The Return of the Political (1993), The Democratic Paradox (2000) and On the Political (2005). (3) Nel libro Il conflitto democratico (2016) Chantal Mouffe afferma: “ ‘il politico’ si riferisce alla dimensione di antagonismo che può assumere molte forme e può emergere in diverse relazioni sociali, una dimensione che non può mai essere eradicata; ‘la politica’ si riferisce all’insieme di pratiche, discorsi e istituzioni che cercano di stabilire un certo ordine e di organizzare la coesistenza umana in condizioni che sono sempre potenzialmente conflittuali perché sono condizionate dalla dimensione de ‘il politico’”. (Mouffe, 2016). (4) Per approfondimenti sulla relazione artista-curatore si rimanda a: Plagens, P., (1969), 557,087, Artforum, 8 (3), pp. 64‒67; Altshuler, B (1998), The Avant-Garde in Exhibitions: New Art in the Twentieth Century, Berkeley and Los Angeles: University of California Press,. Vidokle, A. (2010) Art Without Artists, e-flux journal. (5) Durante una recente conversazione con la curatrice Eva Rowson sul tema dell’ospitalità radicale, ha sottolineato come il termine sia stato con il tempo denaturalizzato, divenendo di fatto un nuovo trend delle principali istituzioni culturali. “Mi trovo ad amministrare simposium sull’ospitalità radicale ospitato da curatori che stanno comodamente seduti in tavole rotonde, senza pensare a coloro che stanno facendo il lavoro sporco o come il budget avrebbe potuto essere redistribuito per coprire le spese di viaggio dei membri dell’audience invece di essere utilizzato per far volare da un altro continente l’ennesimo. Sono diventata sempre più frustrata dal fatto che così tanti eventi istituzionali vengano organizzati con l’obiettivo di discutere su ‘ come reimmaginare il museo’, o mettere in scena ‘ospitalità radicale’ senza prestare alcuna attenzione verso il modo in cui questi eventi sono spesso organizzati, gestiti, pubblicizzati o contabilizzati, e replicando la stessa logica patriarcale, coloniale e tutti quei valori tradizionali che i gli invitati stavano teoricamente cercando di confutare” Rowson, E. (2019). Intervista condotta personalmente da Tea Gradassi, 21 Giugno 2019. Ulteriori riflessioni sul tema: E.R, (in pubblicazione).On Maintaining the Revolution by Being Nice.